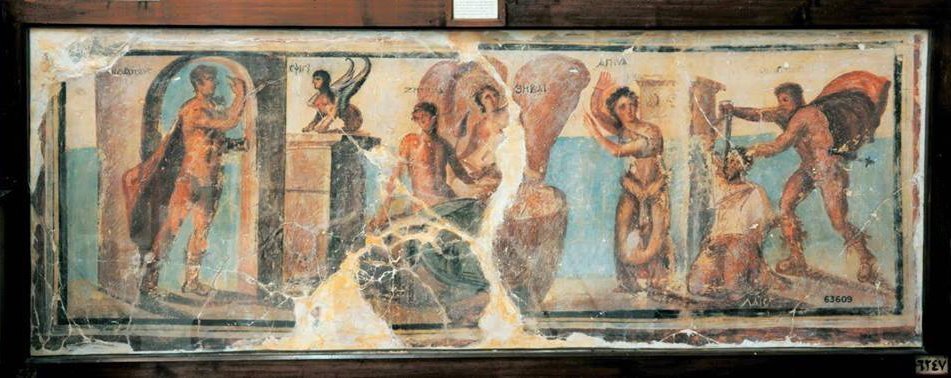NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Ormai sta diventando una consuetudine a dir poco vergognosa, l’allestire fatuo storico, da giugno a settembre e, questo del 2023 in corso e la terza edizione che senza soluzione di continuità espone atti, fotocopie, inesattezze o guerre di pasqua vinte per fare festa.
NAPOLI (di Atanasio Pizzi Basile) – Ormai sta diventando una consuetudine a dir poco vergognosa, l’allestire fatuo storico, da giugno a settembre e, questo del 2023 in corso e la terza edizione che senza soluzione di continuità espone atti, fotocopie, inesattezze o guerre di pasqua vinte per fare festa.
La cosa ancor più grave resta stesa alla luce del sole, ed è il dato del perseverare con attività nell’aia del fatuo a termine, con abbagli storici, stesi senza vergogna, innanzi alle storiche case di quanti conoscono, sanno e così facendo, tutto diviene via crucis in pena di dolore, per chi osserva e ascolta le attività fuori loco e palmo.
Va tuttavia rilevata la pazienza dei saggi, i quali, si dimostrano comprensivi visto il gran numero di comunemente che, ballando e cantando, sventolano natalizi, spargono radici e, per mare tornando a casa.
Scendere con la scopa in mano nell’aia del “trapeso”, sarebbe la cosa più opportuna da farsi, ma chi è saggio usa la scopa per fare altre cose, perché spera che il buon senso deponga radice e, curi le menti di questa schiera d’incultura di “mezza festa”.
Ormai il mese di giugno è considerato la vigilia, “la mezza festa” il momento di tutto quello che rappresenta il nulla per l’Arbër, non resta altro da aggiungere, bisogna solo prendere atto del dato che sono anime in pena lontane dal proprio cuore.
Giugno ormai è da ritenere il mese in cui si manomettono le pietre fondali della storia e, tutto diventa “lecita magistralis”, infatti, sono tanti che scendono armati di chitarre, mantice e tamburello, per indirizzare i/le costumanti/e a turcofone ruotate, cantare e, cosa più grave sollevare la veste del marito e del padre.
Non è concepibile che dall’alto degli scanni, di quanti avrebbe dovuto garantire pubblicamente, misura, parole, atti e cose, come il dovere del ruolo assunto gli imponeva, affermare che: la storia letteraria, della minoranza più longeva del vecchio continente, sia iniziata nel 1831.
Poi se a quest’affermazione, affidano l’operato di nobili eccellenze risalenti al 1775, le stesse volutamente ignorate per dare spazio a una anomala figura, incerta persino della sua natura, il quale poco attento immaginò che catapultarsi a Napoli per cose, nessuno le avrebbe potute riconoscere, come ha fatto il figlio quando ha avut innanzi il copiati dell’opere paterna ancora violato.
Conferma resta il compilante, che si vide costretto a tornare indietro a ricamuffare ogni cosa, con più confusione della sua banalità culturale da allora in poi messa di lato.
Poi germogliarono gli anemici guerrafondai dal vallone senza bandiera, pronti ad armarsi e partire appena odorata la polvere da sparo dei venti rivoluzionari, i quali recatisi in ogni dove, chiedevano ai locali in rivolta, a chi, cosa e dove mirare per seminare morte.
A quanti hanno frequentato quel presidio di incultura “ilibërato” non resta che chiedere di smettere: Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta, Basta e Bastaaaaaaaa…….e se non lo avete capito BASTA, chiudete bottega e fate orti; si, a voi, proprio voi che dite di essere “titolo”, “titolati” e “certificatori”, smettetela una volta per tutte, di seminare grano a giugno, tanto non germoglierà mai e neanche di fatuo a settembre come inconsciamente avete promesso non fate nulla, dopo aver redarguito i saggi che vi superano in ogni dove.
Giugno rappresenta il baricentro della estate Arbanon, il tempo di raccogliere i seminativi per questo bisogna sapere bene quello che si coglie per separarlo dalle cose fatue.
Saper riconoscere e ripetere questi antichi gesti consente al futuro continuità del luogo, in comune convivenza con l’uomo, il mese è il primo momento di esposizione alla calura estive: e non certo è il luogo adatto per esporre neonati in fasce non all’ombra, altrimenti si terminano le cose buone della specie per pochi frutti acerbi.
Ora inizia luglio, riservandoci non certo cose migliori, del mese appena trascorso, certamente si continuerà nel non rispettare uomini, cose, vestizioni, civili, religiose e, si diventerà ancor più estremi, nello smarrire i sensi del protocollo di credenza e onorare, quei tragitti che uniscono tutte le case con la chiesa.
Si vuole sottolineare in questo breve discorso il rispetto che le grandi famiglie hanno sempre avuto per il ricorso dei propri figli, come quando nel 1799 i Serra di Cassano si videro impiccato in maniera a dir poco indecente il figlio Gennaro, rampollo 27enne, essi per questo chiusero il portone che affacciava verso la residenza reale e da oltre duecento anni rimane chiuso in senso di disprezzo verso quella corona, e ancora oggi quell’atto rimane vivo tra quei palazzi, nonostante la prospettiva sia mutata.
Questo, valga di esempio, per chi ha consapevolezza e cognizione di tempo, uomini sangue e cose, alla ricorrenza del luttuoso 18 Agosto, festeggiato perché risultato di conti errati, un falso storico e nulla più, quando a suon di fanfare e onorificenze, ironicamente, pure alla stessa ora, beffa storica di una duplice inforcatura del 1799 e del 1806.
Non è diverso il ricordo degli altri uomini illustri, associato generalmente a nere figure antagoniste, nelle vicende che videro protagonisti glia Arbanon.
I nomi di questi tutti riversati in una cesta per fare estrazione o riffa e, per il sole cocente di mezzo dì, si finisce per estratti come eccellenza, un nero, collocandoli in lapide ricordo con il risultato di 64 certificato per 66 e quindi il giuoco risulta essere truccato.
La letteratura non riconosce a Pasquale Baffi, il dato di essere il primo letterato a comparare le parole Arbër con quanti, con questo popolo, si sino confrontati, per questo è il compositore primo di grammatica e tutto il resto viene dopo.
Se a questo aggiungiamo le disertazioni gratuite di quanti millantano di saper leggere e non riconosce nei discorsi, lo svolgimento dei periodi ad opera del grande letterato sofiota, è il segno inconfutabile che per concorrere al titolo accademico, molti non hanno fatto i compiti a casa e, quello che più conta, non riconoscono la grammatica del maestro con quella di pesatori di grano per tomoli d’interesse.
Si fanno presidi universitari e si perde la mira per la quale scopo furono istituite, tutto questo succede quando non si ha una titolarità specifica dell’argomento, pellegrinaggio senza meta verso le cose moderne che hanno facile misura di tutela, in senso generale, ragion per cui si cerca di innestare l’età della pietra, con l’impero romano, il medio evo e l’era della globalizzazione, senza il minimo riguardo del tempo che tra queste le differenziate.
Il dato che emerge non presta alcuna attenzione alla storia in senso generale e poi come in tutte le cose nessuna attenzione è rivolta alla tutela delle architetture storiche o degli ambiti all’interno dei “centri antichi”, specie nell’esporre cose o fare ricerca verso le attività agresti o la dieta mediterranea, tralasciando i Cunei Agrari, che nella maggior parte dei casi, sono una meteora ignota, comunque non buona da tutelare.
Eppure basterebbe accogliere le figure giuste per intercettare cosa serve e cosa è fatuo, specie per avvicinare i canali turistici che contano, preferendo “bërlocarsi di tutto punto”, per annunciare rapporti intimi e distrarre le piazze divertite, in tutto, continuare ad essere ignari del messaggio inviato.
Cosa dire poi degli inesistenti “Borghi Arbëreshë”, di cui senza formazione si riferisce del costruito, risalente a detta dei cultori, a sei secoli orsono, anche se i materiali dei modelli indicati, descritti e circoscritti, come originali dell’epoca sono tipici delle superfetazioni degli anni sessanta del secolo scorso, a detta sempre degli espositori, ispirati dalle direttive del Cubismo Analitico e Sintetico, in tutto, un penoso falso storico per attrarre ignari turisti, della breve colazione, che partono senza nessuna memoria e contenti di aver mangiato a pranzo.
Se poi il tema diventa la tutela delle parlate locali, oggi tanto in voga e divulgato, per opera di meteore linguistiche a dir poco inopportune, non esistono temi in grado di dare in barlume di fondamento agli orgogliosi alfabetari locali, sbandierati e riverberati ai quattro venti, con le parole Autobus per la “A”; Elefante per la “E”; Pinocchio per la “P”; Orologio per la “O”; Telefono per la “T”; Gorilla per la “G”; ritengo questi accenni siano sufficienti per evitare di scuotere il sonno eterno dei nostri Avi.
Chiaramente soffermarsi sul protocollo della vituperata Gjitonia è un obbligo, specie se diffusa come Vicinato o ancor peggio di Strade, Piazze e Palazzi, questi ultimi fatti di libri rari, portati dall’Albania dentro bauli(?), mentre le altre lastricate di pergamene scritte in latino e greco, tanta cultura alla pari, dei materiali edilizio per fare abusi, come ferro, amianto, plastica e ogni sorta di additivo inquinanti
Si cantano e si ballano valej non avendo alcuna ragione del significato, confuso per battaglia vinta, come se il popolo più antico del vecchio continente, per ballare e per cantare, doveva attendere la Pasqua del 1460 dopo aver fatto strage di uomini donne e bambini.
Altro dato mortificante è allestiscono musei biblioteche e archivi senza che si consulti un luminare titolato per innalzare o articolare questi presidi; potrebbero esser eccellenza, ma si preferisce averli “varruni”, di cose accatastate e delle quali non si conosce, senso direzione, tempo e regole utili alla sostenibilità locale abbandonata così al consiglio del primo viandante, il quale anche se formato non sa e non conosce nulla di quelle pieghe, diplomatiche o temi dirsi voglia locali.
Ormai non si distinguono cosa siano le cose di casa e le cose della credenza, all’interno dei perimetri civili di quelli sacri e le vie del culto, unite indelebilmente.
Ormai oggi tutto si è appiattito ogni cosa è stata cancellata, al punto tale che il capofamiglia del rione Kanun, viene emulato alla pari dei protettori di credenza che dovrebbero essere altra cosa.
Anelli, chiavi, battenti e mezze porte, sono cose della casa, ormai parte anche dei luoghi di culto e, senza misura, grazia, per i Santi che non descrivo più le vie della storia locale, ma diventano luogo dei sani all’inizio dell’evento e, non si ha misura o sostantivo plausibile per “sostenerli” al termine della processione fondamentale per incamerare visibilità degli accasati.
Essere sempre coerente e vicino alle cose, gli uomini, l’ambiente, la storia dai tempi in cui furono e rimasero Arbanon, non importa, resta solo il valore di quanti dicono di sapere, tanto sono e restano, molto più distanti del mio cuore, perché credo sempre nell’essere un Arbëreshë e, non importa altro,
Non bisogna aprissi mai alle cose nuove della vita senza avere riferimenti certi, ovvero come si è stati allevati dai sapienti Genitori e Gjitoni e, tutte le cose che affermano non si citano solamente, ma devono trovare conferma, solo così diventano e sono il momento di conferma per tutti noi.
Mantenere la mente aperta, per un modo profondo e sincero di vedere le cose, senza altri fini o campanili di persone del passato, è l’obbligo che perseguono le persone sagge Arbëreshë.
Viviamo questa vita con il ruolo che una famiglia albanofona, generalmente per discendenza affida a un abilmente dotato, compito non per tutti, ma solo per pochi; in quanto servono anche l’occhi nel cuore, nella mente e, non tutti sono designati per natura ad averne tre.
Non importato cosa cercano di sapere e fanno le altrui genti, né si deve dare peso di cosa sanno e non vogliamo sapere, perché essi comunque vivono lontano dal cuore, perché noi viviamo orgogliosi di essere abilmente dotati.
Ignota rimane l’unità di misura con cui calcolano le cose fatte, sicuramente loro sono molto lontani dal proprio cuore, in quanto non hanno mai provato a credere in cosa siamo e, poco importa cosa diffondono, non importa cosa conoscono e di quanto e di cosa preferiscono contare, ballare o apporre bërlocun.
Esprimersi ermeticamente è l’unico modo per difendere le cose buone, perché quando essi proveranno a capire si comprenderà chi sono i veri ricercatori e quanti vivono a modo inverso, per copiare ricerca altrui.
Tutte queste parole non si affermano per cercare croci di bosco, ma riferisco la fiducia che giunge ogni giorno con cose nuove grazie all’occhio della fronte, del cuore e della mente.
Quello che poi appare è un problema di chi ti deve accogliere e si vergogna, immaginando che due occhi sono meglio di tre.
La mente deve essere aperta per vede cose in Arbanon, non riservare altri fini è obbligo, non importa altro, non importa quello che dicono, non importano i giochi di storia, non importata quello che fanno, non è mai importato quello che sanno, perché la visione trittica non ha rivali e camminare con il vero e, sicuramente state sempre vicino al cuore, credendo per questo sempre in chi e cosa siamo e, non importa nient’altro.
Io sostengo la storia, quella vera, la stessa che ha un inizio, uno svolgimento e il continuo secondo la dinastia di oltre Adriatico ereditata; credo nel Castriota, nella Comneno, nel Baffi, nei Bugliari, nei Giura, nei Torelli, gli Scura e, non importa altro, tanto il resto è noia copiata o riportata per essere illuminati nel palco dei cantanti.
Per terminare si potrebbe ironizzare affermando che tutto quello che è stato fatto per la tutela è finito con il distruggere con largo anticipo, quando doveva essere tutelato e avere più vita e, a ben vedere osservando le ondate che arrivano ad est del fiume Adriatico da un poco di tempo a questa parte, per fini di tutela e cooperazione, peggiora ancor più le cose, cancellando quello che dovevamo difendere.
Restano solo le cose giuste degli ostinati buoni, armati dell’occhio della fronte, del cuore e della mente, i quali continuano a catalogare e scrivere, per lasciare almeno l’impronta di un essere umano, lungo quel solco tracciato il giorno prima del 17 gennaio del 1468 dal Castriota e i suoi fidi.
A queto punto torna in mente uno dei principi delle storiche massaie Arbëreshë, le quali durante la settimana per fare cose dal maiale dove valeva la regola che: nel dubbio mettete tutto nella madia: alla fine facciamo Nduja, tanto, uno disposto a cibarsi, lo troverete sempre da giugno a settembre, dopo il duro lavoro sotto al sole dei campi che hanno già dato.
 NAPOLI (di Atanasio Pizzi Architetto Basile) – Dal XV secolo ha avuto inizio l’avventura che voleva l’Arbër, la lingua esclusivamente parlata da millenni supportata dalle spianate delle favole, la metrica del canto e, rigorosamente non scritta, come altre lingue indo europee, esposta alla pubblica Furcillense, come la Greca e Latina, lette per gli innumerevoli e personalistici alfabetari.
NAPOLI (di Atanasio Pizzi Architetto Basile) – Dal XV secolo ha avuto inizio l’avventura che voleva l’Arbër, la lingua esclusivamente parlata da millenni supportata dalle spianate delle favole, la metrica del canto e, rigorosamente non scritta, come altre lingue indo europee, esposta alla pubblica Furcillense, come la Greca e Latina, lette per gli innumerevoli e personalistici alfabetari.