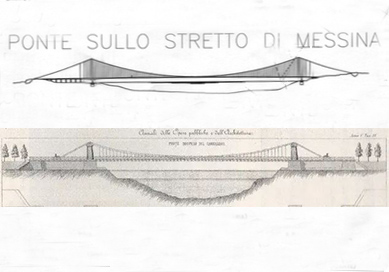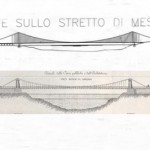NAPOLI (di Atanasio Pizzi Architetto Basile) – Correva il millenovecento e novantacinque, appena finito febbraio e si aprivano gli scenari di primavera, quando si presentarono nella piazza del paese arbëreşë, un Imprenditore Economico e il suo seguito di Muratori, Geometri, Faccendieri e un “Pretore Venduto” e, tutti insieme, dopo aver riunito gli abitanti, li informarono su come si sarebbe dovuto trasformare il loro centro antico, in Borgo.
Aggiungendo che a breve quel centro, sarebbe stato circoscritto da solide mura con una porta sola, dove tutti avrebbero dovuto pagare pegno, ogni volta che vi sarebbero transitati, perché la campagna doveva diventare una discarica, diffusa a cielo aperto a iniziare fuori di quelle mura.
Il progetto che sottraeva l’agro tutto dalle disponibilità degli abitanti, che come tutti sappiamo per gli Arbëreşë storicamente sono risorsa vitale, e cosi tutti sarebbero diventati prigionieri di quelle mura, obbligandoli nel contempo tutti a cambiare mestiere e fare cose inaudite.
Il paese divento così un luogo dove ogni cittadino iniziò a lamentarsi e manifestare il proprio diniego diffuso, perché tutti si vedevano relegati a vivere un nuovo modo, che era un carcere a vita, millantato come una nuova opportunità per il futuro di quel centro parlante e operante in arbëreşë.
A quel punto “i Componenti Storici della Bashkia Locale” proposero un’invito, secondo il loro protocollo di ironia e raggiro.
A questo punto è bene precisare che “i Componenti Storici della Bashkia Locale” era un gruppo di frequentatori dell’angolo della chiesa, dove genericamente si riunivano pensionati o nulla facenti, che qui progettavano pranzi e scherzi di ogni genere, sulla base di una ironia locale.
Essi si appellavano non con il nome ed il cognome, ma con un alias e, i più famosi e continuamente presenti erano, Pizària, Roku, Pizùti, Pedali, Kardakj, Scupkjni, Professùrj, Garibaldi, Lliamallioni e, tutti assieme facevano la Bashkia, sempre pronti a ironizzare sul conto di ogni genere che li si trovava a transitare o dialogare cose assurde.
Questo gruppo una volta che ebbe notizia del cambiamento si recò dal “Pretore Venduto” e, proposero una sfida, o meglio un confronto di dialogo nel piazzale davanti la cantina storica di Mardùminkà, nel corso del quale chi avesse avuto ragione e forza di convincimento del proprio progetto, avrebbe potuto, previo il parere del “Pretore Venduto” avere ragione di futuro.
Nella penombra della cantina storica, incastonata nella zona dei “Baffa di Sotto”, le parti in causa si radunarono in silenzio pesante, ciascuna con il proprio seguito.
I Tradizionalisti o solidi conservatori locali di ironica radice, fieri eredi dell’essere arbëreşë, occupavano il lato occidentale del vicoletto e, i Rinnovatori, con occhi vigili e menti ardenti, sedevano a oriente, il volto contratto in espressioni tese.
Fu il “Pretore Venduto”, arbitro della contesa, fu il primo a rompere il silenzio, affermando: “Che oggi non si alzino spade, ma calici e che il vino sia mediatore e, giudice il tempo di questa riunione.”
Con un gesto largo della mano, ordinò che si versassero le prime botti del vino scuro delle Colline presilane, invecchiato sotto segreto e giuramento, colmò le coppe con riflessi di porpora e cenere.
Gli astanti brindarono, seppur con cautela, ciascuno tenendo un occhio al bicchiere e l’altro al volto dell’avversario.
La discussione, all’inizio, seguì un copione civile e, i Rinnovatori illustrarono i loro piano, secondo un’apertura alla nuova logica del “Borgo Murato” per, il superamento dell’Antico Codice e, la rimozione dei vincoli rispettosi dei cunei agrari che producevano sudore e fatica.
I Tradizionalisti replicavano con pacata fermezza, difendendo la linea della continuità e l’ordine parallelo qui solidamente ricostruito.
Ma fu il secondo vino, quello delle Vigne delle kote, a mutare l’aria, perché colme e dense, di antico, imbottigliate in anni di promesse mantenute e, fu il suo gusto ad aprire le antiche memorie ancora sanguinanti.
Qualcuno, forse per errore o intenzione, lasciò che una parola cadde troppo pesante e, “Tradire il giuramento è come vendere la madre alla Fiera del Soldo!”
Una coppa cadde, poi un’altra e, una sedia fu rovesciata, allora un giovane Rinnovatore balzò in piedi, il volto acceso più dal vino che dall’ira, “E voi preferite marcire nell’obbedienza, come cani legati alla catena di un morto!” e, fu allora che la conciliazione cedette il passo allo scontro.
Il Pretore Venduto batté il bastone tre volte, ma la sua voce fu inghiottita dal frastuono. I calici si rovesciarono, e insieme al vino colarono sul pavimento insulti, vecchi rancori e giuramenti infranti. Alcuni giunsero alle mani, altri si ritirarono in silenzio, come se tutto fosse già stato previsto.
Fu così che quella che doveva essere una tregua, un patto siglato nel vino e nella memoria, si rivelò solo una tregua illusoria.
La Kantina Storica, testimone di antichi accordi e silenzi secolari, si trovò a essere teatro di una frattura insanabile e, all’alba, i due schieramenti lasciarono la sala. Mentre il Pretore restò solo, seduto al tavolo centrale, il volto stanco, il bastone spezzato a metà.
“La pace,” mormorò, “non si versa nei calici, ma si semina nei cuori, tuttavia oggi i cuori… erano già altrove.”
Mentre nella penombra della Cantina Storica si consumava il fallimento del dialogo, altrove, al margine delle vecchie mura, il tempo scorreva in un ritmo diverso.
Il Giovane Architetto Olivetaro, ignaro forse del tumulto o semplicemente disinteressato alle contese vuote, avanzava con passo sicuro nel cuore del Centro Antico.
Al suo seguito camminavano uomini e donne di ogni età, artigiani, contadini, pensatori e sognatori, dei quali nessuno impugnava spada o inneggiava proclami.
Tuttavia ciò che portavano erano attrezzi, mappe, e la volontà di ricostruire, secondo il modello del passato e sotto la bandiera del futuro, secondo la misura dell’essere umano.
Lì, dove si era pensato di fare mura e costringere le genti a sottostare a ragioni assurde, iniziò a prendere forma qualcosa di diverso.
Lo chiamarono Katundë, una parola antica e nuova insieme, il cui suono sembrava evocare radici dimenticate e promesse future, perché esso era un luogo di confronto e movimento per costruire una società nuova fatta di Gjitonie e iunctura familiare.
Non era un villaggio, né una città o borgo, ma era un’intenzione fatta pietra, una comunità nata da mani e scelte, non da decreti o leggi o guerre, ma di una solida interazione basata sull’accoglienza di popoli e generi.
La iunctura familiare, quell’intreccio sacro di legami, reciproca cura e ospitalità, si fece più alta di qualsiasi muro, più solida di ogni muraglia, perché eretta per lavorare e includere.
Nessuna torre, nessuna cinta, ma solo case aperte, cortili comuni, campanili e la voce dei bambini che tornava a riempire l’aria.
Le genti accorrevano, non per combattere, ma per appartenere e, il rinnovamento, così come era stato pensato nella teoria e nella retorica dei suoi promotori, apparve improvvisamente vuoto, distante, scollegato dalla vita vera.
Le genti accorsero dalle valli alte con gerle di semi antichi e mani temprate dal sole e dal gelo, arrivarono anche coi volti impietriti dalla salsedine, portando reti per intrecciare storie e racconti.
Vennero i pastori, gli artigiani, le madri, i vecchi, i bambini e, nessuno era stato chiamato, eppure tutti sapevano, perché era venuto il tempo di rigenerare.
L’Olivetano, tornato tra loro dopo stagioni d’esilio silenzioso, non parlò, ma camminando lento tra i vichi e i vicoli ciechi, dove il muschio aveva inghiottito la pietra e le erbacce spezzato gli stipiti.
Dietro di lui, come un’eco che prende corpo, la gente seguiva, non per curiosità, né per dovere, ma per destino.
Insieme iniziarono a rigenerare case, alcune ormai ridotte a gusci svuotati, vennero ripulite, rintonacate con fango e calce viva, decorate con simboli arcaici che solo gli anziani ricordavano.
Nei vicoli ciechi crebbero orti botanici, fioriti tra le fessure e sorretti da intelaiature rigenerate e, ogni angolo morto venne rivendicato dalla vita.
Gli orti botanici li chiamavano kophëshët nato forse da un sogno, dove venivano piantate varietà salutari il fagiolo del sangue, la lattuga cobalto, il basilico d’ambra, cose che nessun manuale li descriveva più, ma la terra li ricordava.
I cunei dell’agro, un tempo scavati per incanalare l’acqua piovana, ora erano solchi per la semina. L’Olivetano li percorreva all’alba, lento, seminando a mani nude e, dietro di lui, i bambini gettavano i fiori, non per decorare, ma per nutrire.
E gli archi, tanti archi, come bocche antiche riaperte, si svelarono sotto la coltre del tempo, archi che nessuno ricordava più, ma che ora spalancavano la via, la grande via verde che correva come vena viva attraverso l’agro rinato e, chiunque vi passasse sentiva crescere nel petto una musica silente, come un canto di radici e linfa.
Furono ricollocate le antiche targhe toponomastiche e senza errori perché, l’Olivetano sapeva, conosceva e ricordava ogni cosa, supportato dal suo essere studioso storico che non consentiva o conosceva fare errori.
Non era più solo rinascita, ma fioritura, e l’Olivetano, solidamente accolto tra la sua gente come un ulivo millenario, vedeva la nuova stagione innalzarsi, non con clamore, ma con la credenza di un ulivo bianco.
Perché ogni mano aveva toccato la terra, ogni voce aveva cantato la semina, ogni passo aveva scelto il ritorno.
E così, anche ciò che sembrava perduto cominciò a fiorire e, quando il Rinnovatore, col volto contratto e il mantello sporco di vino e vergogna, giunse ai margini del Katundë, vide ciò che non aveva previsto, in tutti la forza tranquilla di ciò che cresce, non di ciò che conquista.
Restò immobile un istante, poi si voltò e, con voce bassa, raccolse il suo sparuto seguito, esclamando: “Andiamocene, qui noi… abbiamo già perso.”
E fu così che il nuovo modo di intendere un luogo vitale vinse, non con la spada, non con il prevaricare, ma con la parola e il lavoro sui campi e la consapevolezza di possedere un tesoro immateriale che non è solo lamento di canto, quello incontaminati con il fare tipico degli arbëreşë e, fu da allora che il Katundë restò, testimone silenzioso di una rivoluzione profonde non di urla, ma silenzioso costruire.
Atanasio Pizzi architetto Olivetano Napoli 2025-07-09